By Gianluca Mantoani
Nel 1887, Maria del Rosario Lopez Real era una cantante molto apprezzata in tutte le cantine del barrio di Santa Ana a Panama. Aveva ventidue anni ed era arrivata in città meno di un paio di anni prima. Veniva da Pocrì de Aguadulce, un gruppetto di case basse addossate alla chiesa di San Juan Bautista, non distante dall’antico villaggio di Natà de los Caballeros, nella provincia di Coclè; una terra boscosa, ricca di montagne, affacciata sull’Oceano Pacifico, grossomodo un centinaio di chilometri ad ovest di Panamà. Una terra ruvida, governata dai latifondisti di discendenza spagnola ma lavorata e abitata quasi esclusivamente dai cholos mestizos, i contadini “mezzosangue”, le famiglie appese alla magra sussistenza della terra, al lavoro delle miniere, alle saline, alla canna da zucchero. La discendenza mescolata delle genti Ngabe-Buglè, dei negros cimarrones, dei lavoratori arrivati da ogni parte dei Caraibi e d’Europa per costruire la ferrovia e poi dispersi in qualunque luogo buono per continuare una vita; magari nelle piantagioni di zucchero o ancora scavando metalli da qualche ferita della terra. Alle loro spalle, nella sierra boscosa, inaccessibile e ribelle stava la rete dei villaggi indigeni e dei palenques protetti da recinti di legno, costruiti e difesi per secoli dalle bande di schiavi fuggitivi e decisi a rimanere liberi; per nulla tranquillizzati dal fatto che, nel 1851, il governo della Nueva Grenada aveva messo ufficialmente fuori legge la schiavitù.
Secondo alcune carte custodite in un vecchio baule di sua nonna (che di nome faceva Maria Lopez esattamente come lei), un giorno di pioggia del 1815 era arrivato a Las Mineras, poca strada da Pocrí e Aguadulce, un uomo di nome Juan Lopez per prendere possesso di una miniera che gli indigeni scavavano da tempo immemore ma che, secondo il Virreinato de Nueva Grenada, era arrivato il momento di assegnare ad un gestore ufficiale, con una concessione scritta. Juan arrivò quel giorno a Las Mineras con le carte legali, qualche attrezzo e tutta la sua vita caricata sopra un carro. Non aveva trent’anni, era nero di occhi e aveva la pelle già corrugata dai viaggi. Bartolina Lilia, che allora aveva quindici anni ed era scura, minuta e davvero bellissima, l’aveva visto arrivare da dietro la tenda, sulla porta della baracca dei suoi e senza dire nulla aveva deciso che quel carro e quell’uomo sarebbero stati la sua casa.
Juan scese dal carro, si presentò ai vecchi del villaggio mostrando le carte che gli davano il diritto di scavare in quei luoghi e disse che, per conto suo, ci sarebbe stato lavoro abbastanza per tutti. Erano gli anni in cui fra Colombia e Venezuela Simon Bolivar combatteva contro il Vicerè Juan José de Sámano e, da quelle parti, nessuno sapeva veramente chi comandasse o chi avrebbe potuto comandare da lì a qualche tempo. Nel dubbio, nessuno si oppose e nessuno gli rispose, sperando che le cose non si mettessero troppo male. Per conto suo, Juan Lopez non fece altri complimenti e pronunciate quelle poche parole, che dovevano essergli costate un notevole sforzo, prese le sue cose e andò a sistemarsi col carro nei pressi di uno dei buchi di accesso della miniera; cominciò subito a costruire una baracca intorno al carro e dopo qualche giorno già iniziava a scavare, si sentivano rumori regolari e continui da fuori l’entrata e, nel giro di due settimane, Bartolina Lilia, la bisnonna di Maria del Rosario, si era trasferita in silenzio nel suo carro, da dove non si sarebbe mai più allontanata.
La prima figlia di Bartolina e Juan, nacque nel giro di un anno e venne chiamata Maria. Trovò il modo di crescere fra tanta carenza di parole e tanto rumore di scavo. Quando arrivò il suo tempo, le donne la isolarono in un capanna per i giorni dovuti, secondo il rituale indio, la lavarono, la rivestirono, le cantarono e le insegnarono le storie e le cose che come donna doveva conoscere. E poi la presentarono al villaggio come adulta, ubriacandola di balli e di chicha di mais fermentato. Imparò camminando e cantando a conoscere i villaggi della sierra, ad ascoltare le storie e le canzoni degli indigeni, dei cholos, le storie di Urracà, di Felipillo e del Rey Bayano, le storie di tutti gli eroi che da tempo immemorabile avevano combattuto per la terra e per la libertà di quella gente, della sua gente. E tutte quelle storie, quella musica, quelle canzoni, quei ritmi di piccone e di tamburi, Maria Lopez li insegnò molti anni dopo a sua nipote Maria, seconda in famiglia con lo stesso nome, alla quale consegnò anche la voce potente, le gambe forti, un’ocarina di legno e la sua memoria prodigiosa. Di questa genealogia Maria del Rosario fece tesoro avidamente e quando, poco dopo aver compiuto i vent’anni, rimase improvvisamente orfana per colpa della febbre gialla aveva già deciso di lasciare Las Mineras, Aguadulce e Natà, la terra dove fino ad allora era cresciuta, per raggiungere Città del Panamà e provare a vivere in modo diverso. Anche se non sapeva nemmeno lei, precisamente, che cosa questo volesse dire.
Ciò che sapeva fare, in quel momento, era in pratica cantare, suonare l’ocarina e raccogliere storie. A Panamà Maria del Rosario trovò il modo di guadagnarsi da vivere cantando dalle parti del mercato, nei locali del barrio de Santa Ana che animavano le serate della “città bassa” e, nel giro di un paio d’anni, passando di bocca in bocca, il suo nome era diventato celebre un po in tutti i locali fra Panama, Colon e le principali città dell’itsmo. Proprio in uno di questi locali la incontrò Albino Malagoni, che ne aveva sentito parlare e, in un certo senso, la stava cercando. La vide entrando dai gradini sulla soglia, mentre lei cantava un tamburito con gli occhi chiusi e si accompagnava unicamente battendo i palmi delle mani sulla sedia davanti. Il locale era scuro, male illuminato e incredibilmente caldo. Maria del Rosario portava una morbida blusa bianca che le cadeva di lato lasciandole scoperta una spalla e indossava una gonna rossa, brillante, lunga sopra la caviglia. Malagoni pensò, guardandola, che quella pelle, lucida di sudore, aveva lo stesso colore del miele di castagne.
Una lunga striscia di stoffa rossa, dello stesso colore della gonna, le risaliva fra i capelli corvini, crespi e lunghissimi. Senza sapere come, Malagoni si trovò ad avanzare nel locale mormorando a mezza voce brani del Cantico dei Cantici, “come nastro di porpora sono le tue labbra” dalla profondità della sua severa educazione lombarda, senza che potesse spiegarselo o controllarlo, il gioco dei colori e dello sguardo riportava alla sua bocca proprio quei brani dell’antico testamento mentre attraversava l’umido e soffocante locale caraibico, trovando vita nel respiro impercettibile che improvvisamente – a volte – lega lo sguardo dissetato alla gola riarsa. Malagoni scavalcò con due spallate le prime file di avventori mentre Maria del Rosario continuava a cantare ad occhi chiusi. “…La tua bocca è piena di fascino” mormorava a bassa voce, girando attorno a due coppie che ballavano “…come spicchio di melagrana è la tua tempia” e avanzava ancora, spostando con la mano un tavolino insieme all’anziano rugoso che stava seduto lì a fumare. “…Il tuo collo è come la torre di Davide” salmodiava ancora, fra i denti e finalmente arrivava davanti a lei; “…i tuoi seni sono come due cerbiatti” gli passò per la mente, facendolo sorridere, proprio nell’istante in cui lei terminava la canzone e apriva lentamente i suoi occhi neri, ovali, tanto brillanti da parere affilati, trovandoselo proprio di fronte, sorridente e come ipnotizzato in un sorriso ebete.

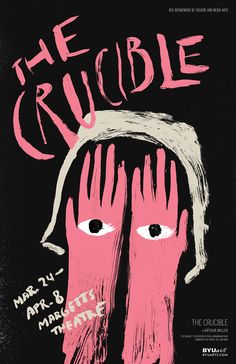



Lascia un commento