La neo-mamma è seduta sul divano nel cuore della notte, che è poi sempre lo stesso cuore, un nocciolo scuro e viscoso di ore indistinte in cui il tempo non avanza ma si accartoccia su se stesso come carta stagnola già usata, e davanti a lei c’è la televisione spenta, uno schermo nero che riflette una versione leggermente deformata del suo viso: occhiaie che sembrano disegnate da qualcuno con un rancore personale, capelli raccolti in una coda che non è più una scelta estetica ma una resa, e le spalle curve come se stessero proteggendo qualcosa di invisibile anche quando la bambina finalmente dorme.
La bambina dorme.
Questo è il dato di partenza, la condizione necessaria ma non sufficiente per il resto della notte.
La casa è silenziosa nel modo in cui solo le case con un neonato riescono a esserlo: non un silenzio pieno, ma uno che vibra di possibilità catastrofiche. Ogni suono potenziale—un singhiozzo, un respiro spezzato, un pianto che potrebbe esplodere come un allarme antincendio—è già presente, in anticipo, come una nota a piè di pagina che il corpo della madre legge anche se la mente vorrebbe ignorarla.
Lei guarda la televisione spenta perché non ha più la forza di guardare altro. I libri sul comodino sono diventati oggetti decorativi, reliquie di una vita in cui l’attenzione era una risorsa disponibile. Il telefono è sul tavolo, a faccia in giù, come un animale morto che potrebbe resuscitare in qualsiasi momento. Il padre della bambina dorme nella stanza accanto, o finge di dormire, o dorme davvero: la differenza, ormai, è teorica.
Poi succede.
La televisione si accende da sola.
Non con un clic deciso, ma con quel suono elettrico incerto, un fruscio breve, come se anche lei fosse sorpresa di essere viva. Lo schermo passa dal nero riflettente a un grigio granuloso, poi a un’immagine che non è un canale, non è un menu, non è nulla che abbia a che fare con l’offerta televisiva contemporanea. È un nastro.
Un nastro che si riavvolge.
La madre non urla. Non si alza. Non chiama nessuno. Perché il corpo, dopo mesi di risvegli notturni, ha smesso di distinguere tra il reale e il plausibile. Se qualcosa di impossibile accade alle tre e diciassette del mattino, la reazione non è più il panico ma una specie di stanca accettazione, come quando la bambina vomita improvvisamente su tre superfici diverse e lei pensa solo: certo, ovviamente.
Sul video scorrono immagini della sua vita, ma non nel modo cinematografico che ci si aspetterebbe. Niente dissolvenze eleganti. Niente colonna sonora. È un montaggio brutale, sbilenco, con salti di qualità e di formato. Lei a ventidue anni che ride troppo forte a una festa universitaria. Lei a ventisei che finge di ascoltare qualcuno parlare di start-up mentre pensa di voler scappare. Lei a trenta che guarda il test di gravidanza come se fosse un oggetto trovato per strada.
Il nastro va all’indietro, veloce, senza chiederle il permesso.
Ed è lì che compare il primo “what if”.
What if non ci fosse la bambina.
Non come tragedia, non come lutto, ma come assenza strutturale, come se quella variabile non fosse mai stata inserita nell’equazione. Lo schermo mostra una versione di lei che dorme tutta la notte. Che si sveglia tardi la domenica. Che ha una carriera che non è straordinaria ma almeno lineare. Una versione di lei che ha ancora l’illusione che la stanchezza sia una condizione temporanea.
La madre sente una fitta allo stomaco che non è rimpianto e non è sollievo, ma una terza cosa, una cosa proibita che non ha ancora un nome ufficiale nel vocabolario delle buone madri.
Poi il nastro scatta di nuovo.
What if non ci fosse il padre.
Qui l’immagine cambia più drasticamente. La versione senza di lui non è più luminosa, ma è più semplice. Meno attrito. Meno frasi lasciate a metà. Meno aspettative non dette che marciscono come cibo dimenticato in frigo. In questa linea temporale alternativa lei è stanca, sì, ma non delusa. Non aspetta che qualcuno “regga”. Non misura ogni gesto di lui su una scala invisibile di promesse fatte e non mantenute.
Perché il problema non è che lui non ami la bambina. Il problema è che lui non è stato all’altezza della versione di sé che lei aveva costruito durante la gravidanza, quella versione eroica, presente, capace di sostenere non solo il peso pratico della genitorialità ma anche quello simbolico, emotivo, mitologico.
Nei mesi passati, lei ha accumulato prove come un pubblico ministero insonne. Le notti in cui lui non si è svegliato. Le volte in cui ha chiesto “dimmi cosa devo fare” invece di farlo. La sensazione costante di essere diventata la project manager di una famiglia appena nata, con scadenze, task e nessun bonus.
Il nastro sembra saperlo.
Mostra scene minuscole, insignificanti agli occhi di chiunque altro, ma devastanti per lei. Lui che si lamenta di essere stanco. Lui che dice “ma io lavoro domani”. Lui che guarda il telefono mentre la bambina piange e lei pensa, con una chiarezza che la spaventa: se non lo fai tu, lo farò io, come sempre.
La televisione accelera.
Il nastro si riavvolge fino a prima di tutto questo. Prima della gravidanza. Prima delle promesse implicite. Prima dell’idea che la maternità avrebbe rivelato una verità più alta, una versione migliore di entrambi.
E lì, improvvisamente, il nastro si ferma.
La madre vede se stessa fare una scelta minuscola. Accettare una cosa invece di un’altra. Tacere invece di parlare. Pensare: andrà bene, invece di chiedere: sei davvero pronto?
La televisione si spegne.
Il silenzio torna, ma non è più lo stesso. È un silenzio che contiene informazione.
La madre si alza lentamente, come se il pavimento fosse diventato più fragile. Va a controllare la bambina. Dorme ancora, con quella fiducia totale che solo chi dipende completamente da un altro essere umano può permettersi. La madre sente qualcosa sciogliersi, non il dubbio, non la rabbia, ma l’idea che tutto questo debba essere perfetto per essere vero.
Torna in soggiorno. Si siede. Guarda il nero dello schermo spento, che ora riflette una donna diversa. Non migliore. Non peggiore. Ma più onesta.
Capisce che il “what if” non è un’alternativa da scegliere, ma uno strumento. Un modo per guardare la propria vita senza anestesia. Capisce che può amare la bambina senza mitizzare la maternità. Che può dubitare del padre senza annullarlo. Che può restare senza smettere di vedere le crepe.
Quando, dalla stanza accanto, lui si muove nel sonno e mormora qualcosa di incomprensibile, lei non prova più l’impulso immediato di catalogare il gesto come prova a favore o contro. Lo lascia essere un suono. Un essere umano imperfetto in una storia che non ha seguito il copione.
La notte non finisce con una rivelazione definitiva. Non c’è redenzione, né rottura. C’è solo una nuova consapevolezza che si deposita lentamente, come polvere: la vita non si riavvolge davvero, ma si può imparare a guardarla senza pretendere che confermi le aspettative che avevamo quando eravamo meno stanchi.
Quando la bambina piange, mezz’ora dopo, la madre si alza subito. Non perché deve. Ma perché vuole. E mentre la prende in braccio, sente che il nastro, quello vero, quello che va solo in avanti, sta ripartendo.
E questa volta, anche se non sa esattamente dove porterà, non distoglie lo sguardo.
[ SiteLink : Volevo fare l’astronauta ]
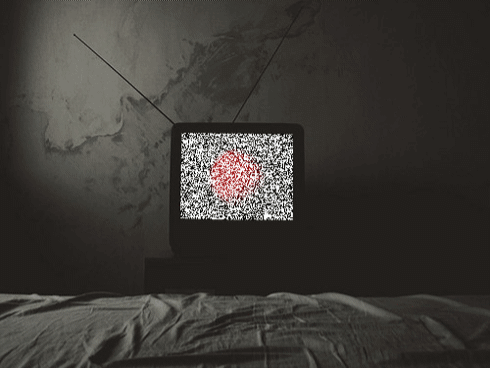




Lascia un commento