Ciao Marcello, grazie per la tua disponibilità.
“Il disinganno prima dell’illusione” è il tuo motto.
1) Qual è la più profonda differenza tra disinganno e disillusione?
Ti ringrazio, Simon James, per avermi posto la domanda e per averla posta in questi termini. Solitamente mi vedo costretto a chiarire l’equivoco con cui di norma si confonde disincanto con disillusione, evidenziando che il primo non ha nulla a che vedere con la seconda, la quale presuppone un essersi tuffato nell’illusione per poi scoprire l’inganno che questa nascondeva, e ritrarsi scoraggiato.
Viceversa il disinganno è un non cadere nel tranello dell’illusione perché già a priori la si riconosce ingannevole.
Disingannarsi non è un atto volontario come non lo è il disilludersi anche se in misura minore. Sono entrambi modi di reagire alla realtà. Mi riferisco ovviamente a chi vive, in modo intensamente intellettivo, le proprie esperienze. Di solito infatti si preferisce illudersi, salvo poi rimanere delusi.
Disingannarsi è un allontanarsi spinto da eventi, sempre dolorosi, che educano a guardarsi intorno e scoprire la vanitas di ogni realtà.
A me lo hanno insegnato involontariamente i miei genitori con metodi che non prevedevano comprensione e dialogo, ma autorità e obbedienza. Cito la frase di Vincent La Soudière che bene spiega il senso di questa mia reminiscenza: ”Se non ho gridato abbastanza nell’attimo in cui sono nato, non è stato per mancanza d’aria, ma per assenza di baci”
Autorità dei miei dunque, che tuttavia la esercitavano in anni di grandi trasformazioni politiche sociali e morali, che rendevano tutto fluido incerto e provvisorio. Autorità e pretesa obbedienza che si sfaldavano come pilastri immersi nel fondo instabile del mare che tempestoso ribolliva intorno.
Sin da piccolo mi rifugiavo in qualche cantuccio. E crescendo ho appreso anche il disinganno di quei poeti, che in quanto tali, lo vivono come l’aria che respirano, anche se lo nominano assai raramente.
Mi permetto di riportare questi miei versi che credo meglio esprimano il mio pensiero riguardo al sorgere in me della necessità del disinganno. (nella poesia mi riferisco alla figura di mio padre e poi a quelle degli autori che mi hanno confermato nelle mie convinzioni: Pavese, Pasolini, Baudelaire)
Una domanda
Fra coloro che senza saperlo mi prodigarono
gli oceani tormentati delle loro anime
con i gesti le parole e i sentimenti
da chi fui generato? Voglio sapere.
Se dal violento che moltiplicava i miei sogni
sfogliando la voce dei morti
e li conficcava come carne nella mia mente
urlando battendo i pugni
sulle spalle della mia fanciullezza.
O dal poeta che mi passò morendo
il veleno del disinganno
e il gusto acido dell’amore rifiutato.
O forse da quel giovane timido
che cercò in sua madre
le dolci forme dell’amore sensuale
e in suo nome lo uccisero.
O dal condannato che vide bruciare
come una fenice i suoi versi francesi
e m’insegnò che i saltimbanchi soltanto
vengono incoronati con l’alloro fiorito.
O dai libri che ho scritto nelle ore grevi
come viso e occhi
sulle consuetudini dell’uomo
sui declivi della vita
sulle forme inafferrabili dell’amore
e nel loro silenzio polveroso ignorano
se esisto ancora.
Voglio sapere. Ma è una domanda
a cui solo i morti possono rispondere.
2) In che modo il disinganno può diventare nostro alleato?
Questa domanda presuppone una volontà volta ad acquisire la capacità del disincantarsi. Essa ha bisogno di una risposta che chiama in causa innumerevoli comportamenti che sono analizzati nella filosofia contenuta del breve Manuale dello stoico Epitteto, che invito tutti a leggere.
Io che ho la fortuna di un’infanzia sfortunata, l’ho letto quando la parole del filosofo hanno assunto il valore di conferma del mio modo di guardare all’esistenza tutta.
Epitteto ovviamente non parla di disinganno né tanto meno di disillusione quanto di felicità o infelicità.
Ma il leggerlo conduce a comprendere la natura del disinganno, come ottenerlo, quali personalità sono in grado di conseguirlo e quanto possa risultare nostro alleato.
Già a partire dal “Preambolo” che Giacomo Leopardi ha posto come prefazione alla sua traduzione del citato Manuale, si è in grado di comprendere come solo coloro che hanno ”cognizione della imbecillità naturale e irreparabile dei viventi” possono trovare un alleato nel disinganno. Il poeta conclude il Preambolo con queste considerazioni: ”Imperocché veramente a ottenere quella miglior condizione di vita e quella sola felicità che si può ritrovare al mondo, non hanno gli uomini finalmente altra via se non questa una, di rinunciare, per così dir, la felicità, ed astenersi quanto è possibile dalla fuga del suo contrario. Ora la noncuranza delle cose di fuori viene a dir questo appunto, cioè non curarsi di essere beato né fuggire di essere infelice. Il quale insegnamento, che è come dire di dovere amar se medesimo con quanto si possa manco di ardore e di tenerezza, si è in verità la cima e la somma di tutta la sapienza umana, in quanto ella appartiene al ben essere dello spirito di ciascuno in particolare. Ed io, che dopo molti travagli dell’animo e molte angosce, ridotto quasi mal mio grado a praticare per abito il predetto insegnamento, ho riportato di così fatta pratica e tuttavia riporto una utilità incredibile.”
Il “non curarsi di essere beato né fuggire di essere infelice” fa pensare al disincanto come a un atteggiamento abulico, indifferente ad ogni emozione, tranne che all’amore per se stessi.
Eppure passeggiamo ammirando ciò che ci circonda, sogniamo mete future e luminose, sogniamo un amore eterno e speriamo d’incontrarlo. Se abbiamo fortuna (o un favorevole Destino) lo incontriamo col desiderio che non abbia mai fine. Ma Stig Dagerman nel suo Vårt behov av tröst (Il nostro bisogno di consolazione) ci dice:“Posso starmene seduto davanti al fuoco nella più sicura delle stanze e, all’improvviso sentire la morte che mi accerchia”. La morte sta lì, dietro l’angolo, dentro un’auto che sbanda all’improvviso e ci viene addosso, in un male che ci rode le viscere, in un medico che sbaglia la diagnosi e di conseguenza la cura (come esempio di male che rode le viscere – e il cuore – ho presente me stesso). O più semplicemente – per rimanere sul campo amoroso – senza scomodare la morte, ma a causa di quello che definiamo cattivo Destino, un altro uomo ci porta via la donna amata.
Ragionando sul non” curarsi di essere beato né fuggire di essere infelice” che ne facciamo del nostro sogno d’amore? Lo abbandoniamo perché vano? Smettiamo di lottare e attendiamo? Ma cosa attendere? E attendere non è illudersi?
Dovremmo anche smettere di dormire e di mangiare, cioè dovremmo smettere di vivere. Questo lo ha fatto Pavese, ma non perché fosse senza sogni, ma perché desiderava sottrarre all’arbitrio del cattivo Destino il modo di andare incontro alla morte. In fondo Pavese era disilluso ma non disingannato, un Pavese che aveva assaggiato il frutto, deluso dalla presenza della scorza.
Il disinganno non toglie il piacere di vivere, quanto piuttosto dona di ogni cosa che viviamo, incontriamo, amiamo, temiamo, l’esatta dimensione della sua natura (il succo del frutto che beviamo, sapendolo custodito dalla scorza).
Per rimanere nell’ambito del tema amoroso, caro a qualsiasi essere umano, il disinganno ci fa chiedere quando finirà l’illusione che stiamo vivendo. “Finirà domani? Allora oggi godrò dell’amore il più possibile, ma ne darò anche affinché lei sappia quanto io l’ami e l’abbia amata.” E questo vale per l’impegno civile e sociale che ciascuno dovrebbe nutrire.
Ma tutto questo non vuol dire che il disinganno mi pone al riparo dal dolore, dall’amarezza, dalla paura, dal desiderio di porre fine alla mia vita.
3) Quanto coraggio serve per vivere il disinganno?
Se osservo il mio vivere, mi accorgo della mia precarietà, del mio essere nulla di fronte agli eventi della vita, miei, dei miei cari, del mondo, della mia impossibilità di agire sull’essere umano, sulla sua crudeltà nell’esercitare l’ingiustizia e sulla sua pervicace illusione di esercitare il potere sui suoi simili e sulla natura. Il disinganno è sapere che tutto non è che un’illusione, un’amara, infelice illusione. Accettare? No! Lottare sapendo che la lotta è già perduta.
Ci vuole coraggio. Molto coraggio per amare ciò che non si potrà mai possedere o che possedendolo, si sa che andrà perduto.
Ma se si avrà questo coraggio, il vivere nel disinganno metterà in grado ciascuno di bere e gustare il succo di ogni frutto, nonostante la scorza.
Leopardi ancora una volta lo insegna con i suoi versi e la sua vita e mostra anche che il coraggio genera fantasia e immaginazione. Ecco a cosa giova il disinganno: a creare quel grande motore che si chiama utopia, vivendo e sviluppando le grandi risorse dell’essere umano, nonostante l’ineluttabile agguato della morte.
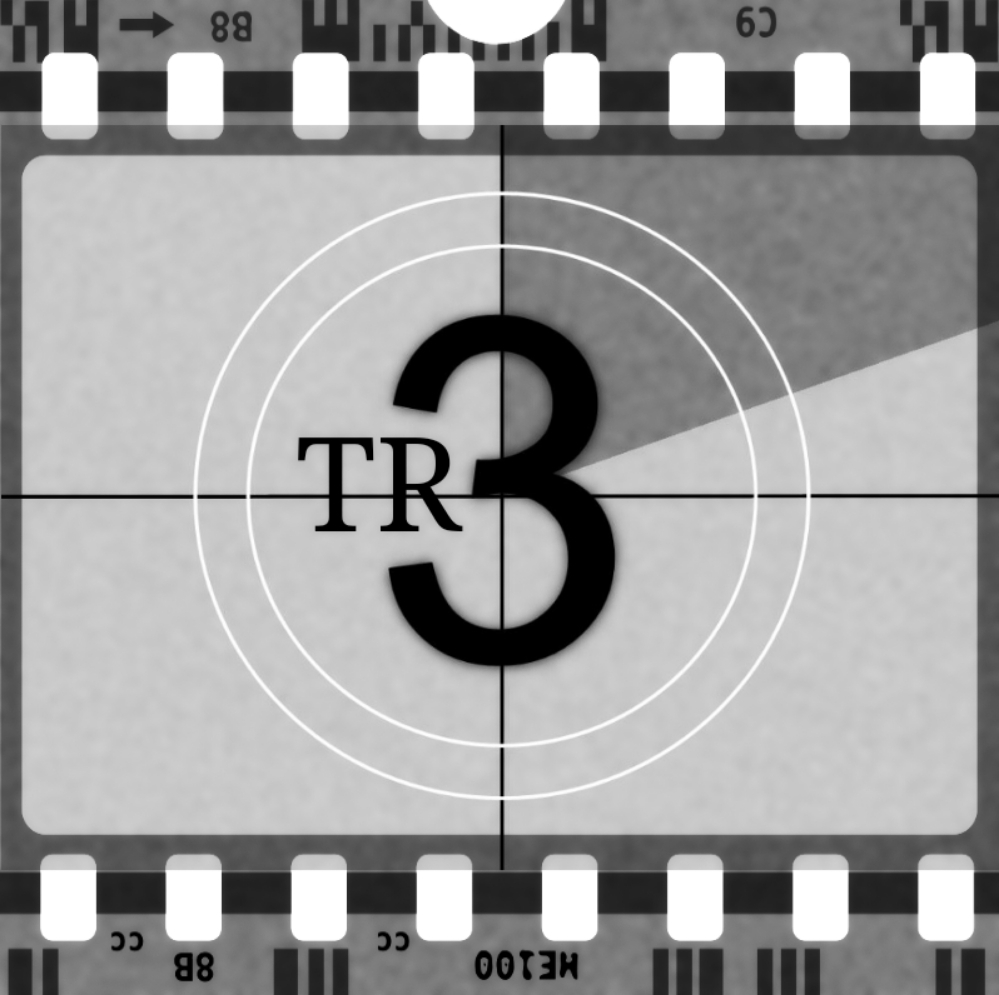




Scrivi una risposta a marcello comitini Cancella risposta