Il bambino, di Fernando Aramburu, Guanda 2024, traduzione di Bruno Arpaia, pp. 272
Fernando Aramburu, noto per la sua attitudine a scavare nelle ferite aperte della società, affronta in Il bambino un evento tragico che ha segnato profondamente la Spagna.
Lo scrittore prende ispirazione dalla tragedia di Ortuella (Vizcaya). Quel 23 ottobre 1980 si registrò la morte di 50 bambini e 3 adulti in seguito all’esplosione accidentale di una sacca di gas propano accumulata sotto la scuola pubblica.
Un tragico fatto di cronaca che ha mietuto vittime innocenti, segnando profondamente le persone, diventa per l’autore un pretesto per indagare le profondità dell’animo umano di fronte alla perdita e al dolore, insistendo sulle diverse sfaccettature del dolore: la rabbia, la disperazione, la rassegnazione, ma anche la capacità di resistere e di ritrovare un senso alla vita. L’autore ci mostra come il trauma di un evento del genere possa lasciare cicatrici profonde e durature, trasformando radicalmente l’identità di un individuo.
Come in Patria (secondo me, uno dei più bei romanzi che ho letto negli ultimi dieci anni), Aramburu evita le facili scorciatoie, preferendo immergersi nelle complessità di una comunità segnata dal lutto, restituendo al lettore un ritratto vivido e autentico.
Con una delicatezza quasi chirurgica, Aramburu disseziona l’animo umano, svelando le ferite profonde che la perdita di un figlio può infliggere. María José, José Miguel e il vecchio Nicasio diventano i protagonisti di un’odissea interiore, un viaggio alla scoperta di sé attraverso il dolore. La prosa di Aramburu, precisa e raffinata, ci accompagna in questo percorso, catturando le più sottili sfumature emotive. Il narratore, come un osservatore attento e discreto, ci offre uno spaccato intimo e autentico di una famiglia in lutto, rivelando la complessità e la fragilità dell’esistenza umana.
Nel fluire del racconto, il tempo sembra dilatarsi e contrarsi, intrecciando passato, presente e futuro. Attraverso un sapiente gioco di flashback e flashforward, Aramburu ricostruisce la storia della famiglia, svelandoci gradualmente i dettagli della tragedia e le sue conseguenze. La narrazione, scorrevole e coinvolgente, ci trasporta in un mondo dove il confine tra realtà e memoria si fa labile. Il narratore, come un tessitore paziente, unisce i frammenti di una storia spezzata, creando un tappeto ricco di sfumature e significati.
Il romanzo, in dieci occasioni, interrompe la narrazione per rivolgersi direttamente al lettore. Questa audace scelta stilistica, definibile come un dispositivo meta-narrativo, conferisce al testo una consapevolezza di sé quasi ironica. Il romanzo, infatti, non si limita a raccontare una storia, ma riflette anche sul proprio processo di creazione. Queste pause narrative servono a diversi scopi: da un lato, offrono al lettore approfondimenti e dettagli che arricchiscono la comprensione della trama; dall’altro, creano una sorta di distanza critica, ricordandoci che stiamo leggendo un’opera di finzione, pur immersiva e coinvolgente.
Nicasio, figura emblematica di un dolore che sfiora la follia, incarna l’ambivalenza di fronte alla perdita. Il suo dialogo costante con il piccolo Nuco trascende i confini della realtà, creando un limbo sospeso tra ricordo e immaginazione. Nicasio non è solo un evocatore di fantasmi, ma un custode della memoria che, con la sua lucidità malinconica, offre al lettore una prospettiva unica sulla tragedia. Di fronte all’abisso della morte, la razionalità si rivela impotente.
Oltre al toccante ritratto del nonno Nicasio, spicca la figura della madre Mariaje, combattuta tra il desiderio di ricominciare e il peso dei segreti che hanno segnato il suo matrimonio. Mariaje è un personaggio complesso, attraversato da sentimenti contraddittori. Da un lato, il desiderio di dimenticare il dolore della perdita; dall’altro, il bisogno di ricordare il figlio e di mantenere viva la sua memoria. Questa ambivalenza la porta a vivere in una continua tensione, ma è proprio questa tensione che la spinge a cercare nuove vie per dare un senso alla sua vita.
Il padre José Miguel, invece, incarna la fragilità e la speranza di un uomo semplice che cerca di aggrapparsi a ciò che resta della sua famiglia.
La frase “Soffrire non serve a niente”, pronunciata da uno dei personaggi, risuona come un’eco delle riflessioni pessimistiche di Cesare Pavese. Tuttavia, questa affermazione non esaurisce la complessità del romanzo. L’autore, infatti, ci invita a non fermarci alle parole dei personaggi, spesso determinate dal loro specifico momento storico. Il romanzo, pur partendo da una tragedia, non è un’elegia alla sofferenza, ma un’indagine sul modo in cui gli individui cercano di ricostruire la propria vita dopo una perdita. È un percorso di rinascita, non privo di ombre, ma teso verso un futuro possibile.
In questo nuovo e come sempre profondo romanzo Aramburu ci invita a immergerci in un flusso narrativo che, come un fiume in piena, trascina con sé il lettore in un vortice di emozioni.
Qui potete leggere l’incipit del romanzo.

Fernando Aramburu, nato a San Sebastián nel 1959, ha studiato Filologia ispanica all’Università di Saragozza e negli anni Novanta si è trasferito in Germania per insegnare spagnolo. Dal 2009 ha abbandonato la docenza per dedicarsi alla scrittura e alle collaborazioni giornalistiche. Patria, grande successo di critica e di pubblico in Spagna, vincitore del Premio de la Crítica, tradotto in 34 lingue, è stato pubblicato nel 2017 da Guanda e ha avuto anche in Italia una straordinaria accoglienza, vincendo il Premio Strega Europeo e il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nel 2020 Guanda ha pubblicato un graphic novel ispirato al romanzo. Sempre per Guanda sono usciti gli altri suoi libri: Anni lenti, Dopo le fiamme, Mariluz e le sue strane avventure, Il rumore di quest’epoca, I rondoni e Figli della favola.
Il suo ultimo romanzo è Il bambino, da cui verrà tratto un film, scritto e diretto da Mariano Barroso, in uscita su Netflix.
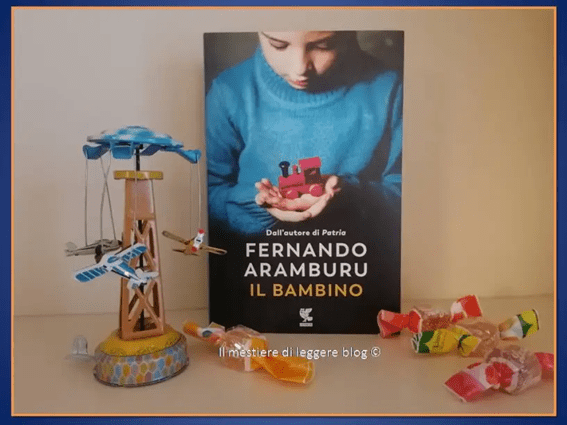




Scrivi una risposta a gattapazza Cancella risposta